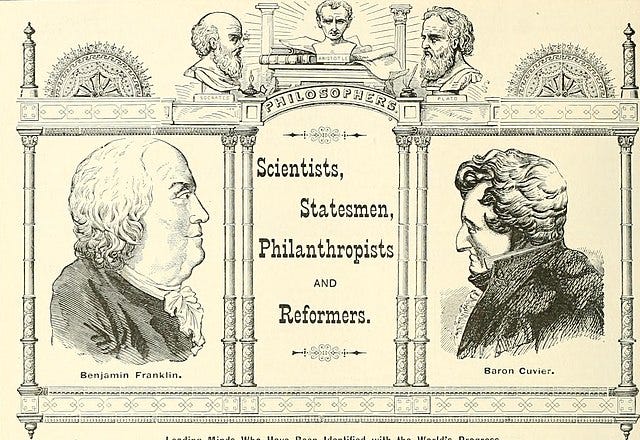Vite di scienziate - La biografia al femminile
Quarto numero dedicato alle biografie di scienziate/i. Dove me la prendo con le storie di scienza al femminile e con i racconti di scienziate "ribelli". Stavolta sì che mi faccio delle amiche.
Ho fatto un giro per le librerie di casa (consideriamola un’indagine a campione). Ho trovato diverse, non molte, biografie di scienziati uomini, e diverse, un po’ meno, biografie di scienziate donne.
Dato comune: ci sono personaggi ai quali sono state dedicate molte biografie. La mia impressione è che il lavoro di un primo biografo abbia ispirato e facilitato quello dei successivi: del resto nessuno inventa mai niente di veramente nuovo su questa Terra.
Franklin e Cuvier: ecco chi metteva in copertina il pittore Thomas Edie Hill nel suo libro di ritratti di “persone che sono state e sono importanti come religiosi, eroi militari, inventori, finanzieri, scienziati, esploratori, scrittori, medici, attori, avvocati, musicisti, artisti, poeti, sovrani, umoristi, oratori e statisti, insieme a capitoli relativi alla storia, alla scienza e ai lavori importanti in cui le persone di spicco sono state impegnate in vari periodi di tempo”, del 1887. Il titolo del libro l’ho fatto tradurre dall’intelligenza artificiale, che se ne frega di mettere i femminili. Del resto, credo che anche Thomas Edie Hill nel suo libro non abbia inserito una donna nemmeno per sbaglio. Se avete voglia di sfogliare 587 pagine, ecco il link.
Tra gli uomini, ho trovato più di una biografia di Einstein, con qualche colpo di fantasia come la biografia dell’equazione E=mc2 nell’omonimo libro di David Bodanis.
Ho trovato molte storie di scienza che riguardano collettivi di scienziati: a me per esempio è piaciuto molto “La brigata dei bastardi ” di Sam Kean (Adelphi), la vera storia di come gli americani si convinsero che la Germania avrebbe potuto costruire la bomba atomica prima di loro, e di come misero in campo un pittoresco gruppo di spionaggio.
In generale mi pare che, con l’eccezione di Pitagora, Fibonacci, Galileo Galilei, Charles Darwin, la maggior parte delle biografie abbia per protagonista un fisico del Novecento. Alcune viaggiano attraverso storie a loro collegate, quasi tutte sullo sviluppo della bomba atomica. Il fatto che siano maschi non viene mai sottolineato, è scontato.
Considero due bias: a fare la scienza fino a qualche decennio fa erano soprattutto gli uomini (quindi è comprensibile che siano più presenti) e a raccontare la scienza anche.
Di biografie di scienziate mi pare di averne trovate un po’ meno, o comunque mi pare che siano libri meno importanti, meno monumentali, meno tradotti, scritti da autori meno famosi. Me lo conferma anche una ricerca in rete: le biografie più famose, tradotte, lette, trasformate in film, sono di maschi scritte da maschi.
Forse fa eccezione Marie Curie, sulla quale solo di recente ho visto almeno due spettacoli teatrali, e direi anche Rosalind Franklin. Per entrambe, è dominante il tema dell’ingiustizia subita.
Nella mia libreria trovo le biografie delle bandiere della scienza al femminile come Lise Meitner e Trotula, entrambe raccontate tra gli altri da Pietro Greco, anche lui mio maestro e amico, sempre molto attento al tema delle donne nella scienza. Ci sono poi Margherita Hack, Rita Levi Montalcini, le primatologhe, le donne dello spazio e qualche altra campionessa.
Eccezione lodevole: “La ragazza con il compasso d’oro. La straordinaria vita della scienziata Émilie du Châtelet”, libro molto godibile scritto da Paola Cosmacini (Sellerio).
Altra eccezione importante, un classico dei libri a tema scientifico, “La vita immortale di Henrietta Lacks”, di Rebecca Skloot (Adelphi), in cui le protagoniste sono una povera donna morta di cancro nel 1951 e le sue cellule tumorali pressoché immortali. Anche qui, il tema è l’ingiustizia o quantomeno la necessità di una discussione etica, ma se Henrietta fosse stata maschio (e persino bianco) la storia sarebbe stata solo meno interessante ma la sua morale non sarebbe cambiata.
Trovo soprattutto molte raccolte di storie di scienziate, messe insieme per l’unica ragione di essere tutte femmine. Spesso hanno titoli collettivi che sottolineano il loro carattere ribelle oppure le discriminazioni che hanno dovuto subire: a volte sono loro dedicate intere collane.
Su questo vorrei provare a riflettere.
Le biografie delle scienziate, come i convegni, le mostre, le conferenze, le trasmissioni radiofoniche e televisive e i documentari dedicati al tema, hanno una funzione importante: hanno permesso, e permettono, di sottolineare che le donne nella scienza hanno incontrato spesso difficoltà a lavorare, a volte anche ad avvicinarsi alle porte di una facoltà scientifica. E tuttora incontrano ostacoli, visibili o invisibili, al lavoro e a casa, che fanno sì che i numeri raccontino di un mondo non ancora paritario.
Le cose stanno cambiando e probabilmente certi sforzi editoriali hanno i loro meriti, in ogni caso è evidente che c’è ancora un sacco da lavorare.
Però i libri… Perdonatemi, ma all’ennesimo libro sulle scienziate ribelli mi sono trovata a pensare che, dai e dai, deve essere diventata una moda.
Non ho niente contro le mode, eh. Ed è chiaro che quelli come me, che scrivono libri per lavoro, annusano la temperie e progettano libri sulla base dei loro auspicabili futuri commerciali. Anche perché se a un editore oggi proponete un libro vagamente anti-mainstream sul tema (non sto dicendo un libro dal titolo “Abbasso le donne nella scienza” o “Non è vero che sono discriminate”, alla Vannacci: intendo un libro un po’ meno celebrativo) è molto probabile che l’editore vi dica che non vede il pubblico adatto. Ed è vero. Oggi in libreria ci va sempre meno gente: se c’è un genere che ancora vende, non sputiamoci sopra.
Però insomma, un attimo. A furia di parlare di ribelli, non è che siamo diventate conformiste?
Se è davvero così, questo mi pare che apra a un altro problema: come vi ho raccontato nel numero scorso, storici e storiche della scienza nutrono molte diffidenze verso le biografie scritte dai raccontatori di scienza. Sostanzialmente, il punto è che quelli come me tendono a estrarre il personaggio dal suo contesto e a raccontarlo in maniera sempre un po’ enfatica.
Ma se a romanzare una biografia penso che non sia niente di male (va dichiarato, eh), a scrivere una biografia senza rendersi conto di fare un’operazione romanzo, con la protagonista che si mangia tutta la scena, beh qualcosa di sbagliato c’è.
Ero più o meno a questo punto della mia personale riflessione, quando una biografia di scienziata è stata chiesta a me. Un po’ ho tremato.
Si trattava della biografia di Eva Mameli Calvino per la collana Oilà della casa editrice Electa, collana diretta da Chiara Alessi. La collana è composta da libri che raccontano le storie di alcune donne del Novecento: libri veloci ma molto curati, tutti scritti in maniera personale da autrici scelte per una qualche contiguità con la figura raccontata.
Ma io? Io non sono botanica, non sono agronoma, non sono sarda (come Eva Mameli Calvino) né ligure (Eva Mameli Calvino ha vissuto più di metà della sua vita a Sanremo), non sono un’esperta di niente. Però Chiara ha insistito, e a me lei sta simpatica, Eva Mameli Calvino anche, la collana Oilà è bella: quindi ho detto di sì e mi sono messa a studiare.
La prima cosa che ho scoperto è che su Eva Mameli Calvino esistevano già non solo alcune biografie, ma anche alcune ricerche di ambito accademico. E ho tremato ancora di più.
Ho cercato tra le foto in public domain “Eva Mameli” e ho trovato tante fotografie familiari come questa, tutte con titoli come “Italo Calvino e famiglia”. Qui, si sottolinea, Italo è con i suoi genitori. Per amor di precisione, aggiungo che Eva è quella a sinistra nella foto.
Dopo un po’ che raccoglievo materiale, ho dovuto riconoscere di esserci caduta con tutte le scarpe: ero incappata in una scienziata per niente ribelle. Era successo: non avrei potuto infilarmi nel mainstream e fare contenti tutti con la solita storia di una scienziata battagliera. Anche perché, essendo già stata molto raccontata, non potevo inventarmi una Eva come piaceva a me.
Eva Mameli Calvino non ha mai sbattuto le porte, puntato i piedi, montato barricate: era anzi fieramente sorella, moglie e mamma. E mai e poi mai ha scritto di difficoltà nello studio o nel lavoro, dando la serena impressione di non averne mai avute. Aveva potuto studiare all’università, pubblicare a proprio nome, ottenere cattedre e posizioni nella ricerca pagata con regolare stipendio. Fortuna? Anche.
Sicuramente accanto a lei c’erano donne diverse e sicuramente la maggior parte delle ragazze ai suoi tempi non cominciava nemmeno il liceo, figuriamoci la carriera universitaria o il giro del mondo. Ma lei, Eva, non ne ha mai parlato.
Anzi. Nel 1921, nel periodo cubano, ha scritto un articolo dal titolo “La mujer en los institutos cientificos de Pavia, Italia” in cui vantava i risultati delle donne scienziate di Pavia, città nella quale si era formata, e mostrava il progresso delle donne nell’accademia italiana, lei inclusa.
Ho poi scoperto che ai primi del Novecento non era così inusuale che una donna della buona borghesia intellettuale progressista fosse libera di studiare all’università, in Italia. Magari poi la laurea la appendeva in salotto, però il diletto di frequentare un corso di laurea a qualcuna era concesso. E c’era anche chi veniva dall’estero a studiare da noi, perché l’ambiente italiano era molto più aperto e favorevole alle donne di quello di tanti altri paesi europei.
Ecco forse perché Eva non vedeva il problema. Perché nessuno le ha impedito di scegliere di studiare scienza. Erano poche, le ragazze in facoltà, ma prima di lei erano di meno e in quel momento stavano crescendo (c’era anche una professoressa a Pavia, si chiamava Rina Monti Stella). Eva vedeva la crescita dei numeri, forse, non il numero assoluto.
Ovvio, a noi può sembrare strano: noi puntiamo al 50/50 tra maschi e femmine, ovunque. Ma queste siamo noi oggi. Non confondiamo i nostri obiettivi con quello che può aver pensato una ragazza del 1886.
E non forziamo le cose. Continuo a vedere in giro descrizioni di lei e della sua vita che enfatizzano i suoi primati (prima donna a ottenere la cattedra di botanica in Italia, prima direttrice di orto botanico in Italia…) o che dicono che ha infranto qualche regola (ma quale?) o che le tolgono il cognome Calvino che lei aveva liberamente aggiunto al suo quattro anni dopo il matrimonio. Mi sembra poco rispettoso nei confronti di Eva e dei lettori e delle lettrici di oggi. E forse dobbiamo anche ammettere che Eva Mameli Calvino ha avuto il privilegio di tante biografie, compresa la mia, perché ha avuto un figlio di nome Italo di mestiere grande scrittore.
Piuttosto, mi sembra molto giusto impegnarsi a raccontare le donne scienziate che sono state poco visibili nella storia, e hanno lavorato spesso in ombra rispetto ai loro colleghi maschi ma mai con risultati inferiori. E sono finite nel dimenticatoio perché a raccontare la scienza sono (stati) soprattutto i maschi. Anche perché sennò continuiamo a raccontarci di Rosalind Franklin o di Marie Curie, e a ogni passaggio le trasformiamo in donne sempre più straordinarie.
Certo, raccontare quelle come Rina Monti Stella è più difficile. Sono storie meno avventurose, le loro, con meno colpi di scena e soprattutto ci sono pochi lavori predigeriti da cui partire. Questa cosa delle informazioni è cruciale e straziante. Per dire: tutte le volte che presento “Eroica, folle e visionaria” qualcuno mi fa notare che ci sono poche donne, come se fosse colpa mia. Ma non ho trovato autoesperimenti del genere WOW! intestati a donne, semplicemente perché un tempo le donne non facevano esperimenti in medicina. Però non è vero che non ci sono donne nel libro: ogni tanto ne compare qualcuna, geniale o provvidenziale, solo che su di lei, per me,
è stato impossibile trovare informazioni. Accidenti.
Questa foto la trovo così, con scritto Rina Monti, ma con il titolo “Rina Monti Stella”. Credo che anche Rina Monti avesse aggiunto il cognome del marito (Stella) dopo il matrimonio. Non so: magari questa foto è anteriore al matrimonio (cosa che giustificherebbe la scritta a penna) ma è conservata in un fondo dedicato a lei e chiamato con il nome completo che si era scelta (mi risulta al Museo civico Castello Ursino di Catania). No idea.
Questo a me sembra ingiusto: le donne nella scienza ci sono state, poche ma ci sono stete, e le abbiamo perse. E adesso ci troviamo a raccontare sempre le stesse dieci, sottolineando la loro ribellione e magari copiandoci a vicenda.
Ecco: raccontiamole di più, le scienziate, ma raccontiamole meglio.
Poi ci sono le bambine. E allora, come di consueto: appuntamento al prossimo numero.
(Non è del tutto pertinente, e ha provocato un po’ anche me, ma questa è una delle cose più intelligenti e divertenti che abbia visto ultimamente sul tema. Emanuela Fanelli è del 1986).