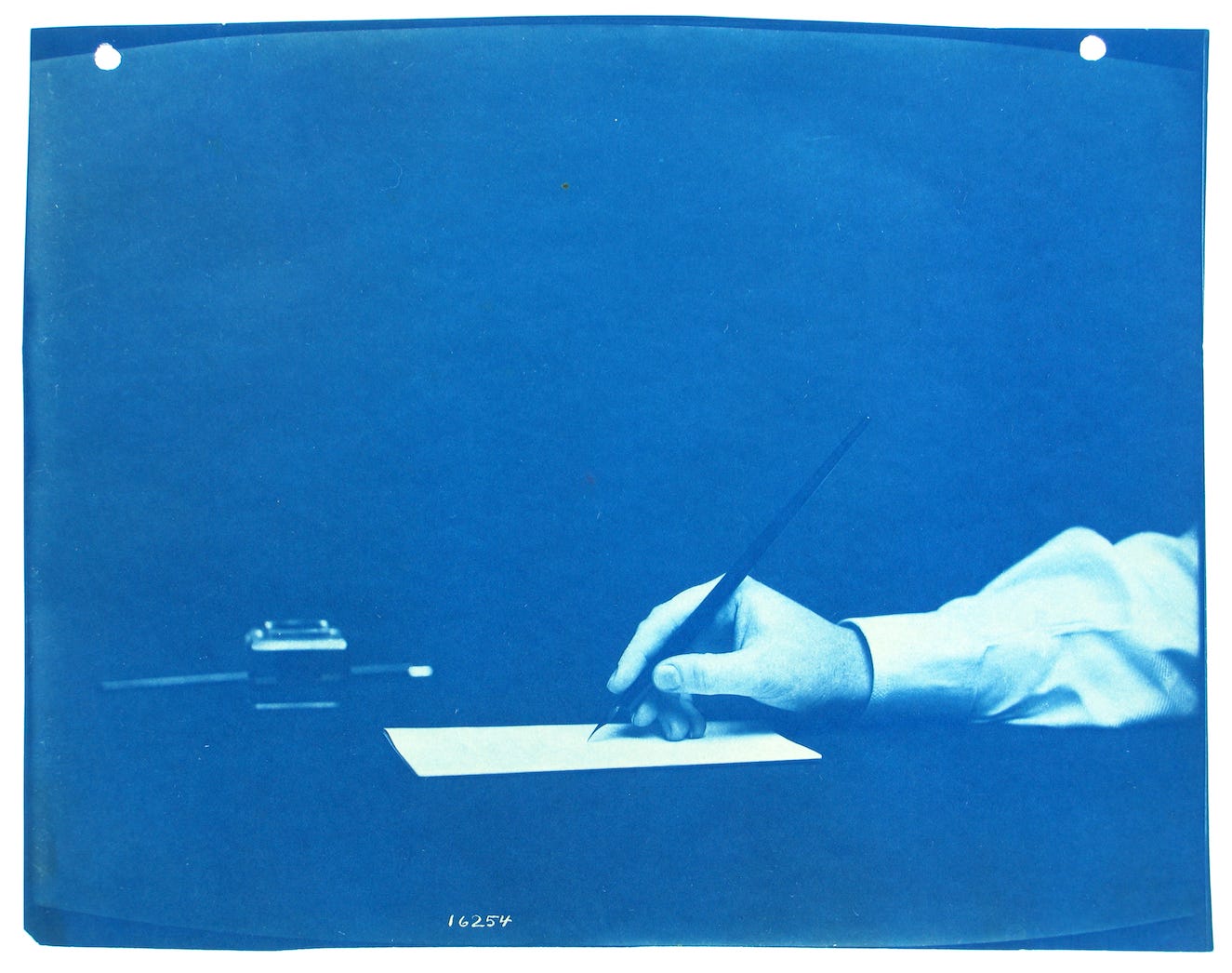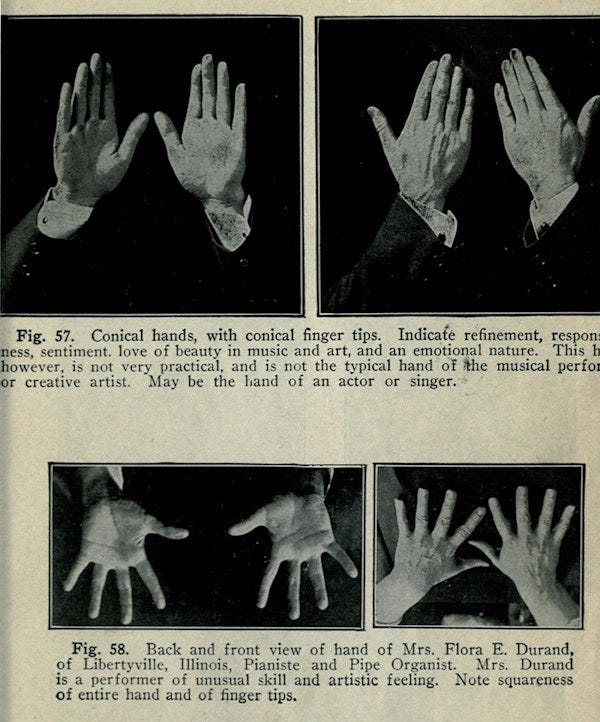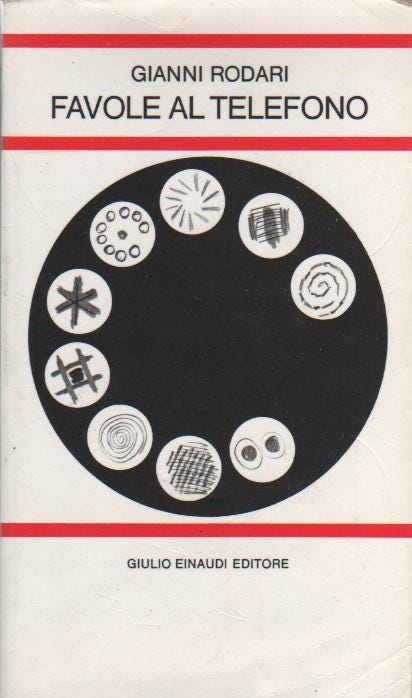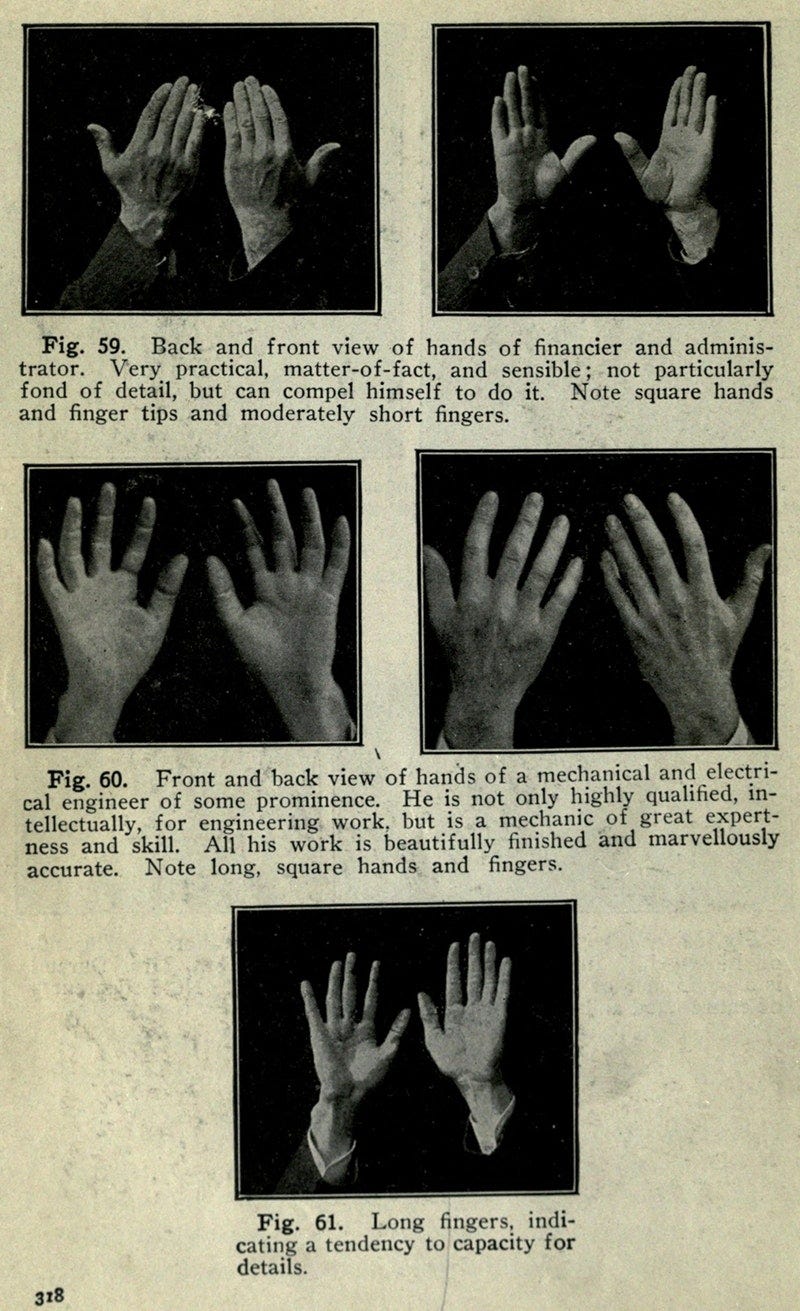Vite di scienziati - Si fa presto a dire "biografia"
Dove si affronta la teoria e si finisce per dire che, in fondo, una biografia può anche non essere una vera biografia. Purché sia dichiarato e non si inganni il lettore.
Sono al terzo numero di questa newsletter e sto continuando a scrivere di biografie di scienziati. Per di più ne ho nominate solo quattro, e non è un gran risultato per una newsletter che promette di parlare di libri. Ma il punto è che quando, circa un anno e mezzo fa, mi sono messa a scrivere la biografia di uno scienziato dopo aver scritto la biografia di una scienziata (ne parleremo), ho scoperto che sul tema “biografie di scienziati” c’è gente che ha studiato.
Cioè come (quasi) sempre, mi sono trovata nei panni della “comunicatrice” che ha preso ed è partita, e si è messa a fare cose per entusiasmo, illudendosi che bastassero l’impegno, la curiosità e una buona penna. A noi “comunicatori” accade spesso, o meglio a me è accaduto mille volte: penso di avere una buona idea e comincio a giocherellarci. Poi, e solo poi, scopro che ci sono tonnellate di scritti teorici (non sempre così inutili), di professionalità ben costruite e di esperienze pregresse che, almeno su quello specifico tema o su quello specifico modo di affrontarlo, avrei dovuto considerare per fare meglio il mio lavoro.
La figura che avrei usato come intestazione dell’intera newsletter, se avessi capito come si fa. La fotografia è di Thomas William Smillie (1843–1917), che, quando fu nominato “curatore della collezioni fotografiche” dello Smithsonian Institution di Washington nel 1896 era il primo “curatore di collezioni fotografiche” della storia.
È successo anche con le biografie degli scienziati. Mentre ero lì che scrivevo e mi divertivo come una matta, ho scoperto un paio di paper che mi dicevano cose interessanti.
Per esempio c’è tutto un filone di riflessione femminile e/o femminista sulle biografie delle donne scienziate, come quella di Barbara McClintock di cui ho parlato nel numero scorso. È interessantissimo, e a volte contiene argomentazioni per me nuove, del tipo: guardate che non è mica sbagliato puntare il dito su figli, famiglia, impegni domestici e focolari, e sulla difficoltà di conciliare tutto questo con il laboratorio per una donna e solo per una donna. Perché significa esplorare i contesti sociali, e non solo personali, in cui si muove una scienziata. Significa - come in ogni buona biografia di scienziata/o - raccontare lei ma anche il suo mondo, che è ed è stato il mondo di tanti e di tante.
(Mi chiedo se valga anche per gli articoli di giornale, che invece quando puntano il dito su “scienziata e mamma” ci indispettiscono da morire. Chiederò).
Poco più in là c’è il tema della costruzione dei contorni del personaggio e di quel che c’è oltre, e quindi anche delle biografie dal sapore nazionalistico, delle biografie celebrative. E di quelle scritte allo scopo di affermare un’ideologia, un pensiero, o anche di rivendicare i diritti di un gruppo sociale o etnico, in qualche modo politiche.
Mi viene da sorridere ma credo che vadano in questa categoria, o poco accanto, le biografie minuscole degli eroi misconosciuti scritti dagli storici fai-da-te della provincia italiana, che ogni tanto producono la vita del Pasteur della Valdiqualcosa o del Newton della Piandiqualcosaltro. Genere adorabile e sempre foriero di grandi godimenti, per noi curiosi.
Tra le tante cose che scopro leggendo pagine che probabilmente uno studente di lettere o storia affronta al primo anno di università (noi nati scienziati siamo grandi presuntuosi, diciamocelo) c’è la riflessione a proposito dell’identificazione tra biografato e biografo e dell’accettabilità della prima persona, di cui io, pensando di essere chissà quanto originale, ho fatto ampio uso in entrambe le biografie. Ecco, scopro che su questo c’è gente che dibatte e litiga dagli anni Settanta.
In particolare trovo una frase dello storico Arnaldo Momigliano, che in apertura di un suo monumentale lavoro sulla biografia nell’antica Grecia uscito per Einaudi nel 1974 (non pensiate che l’abbia mai letto) scrisse: “Quando ero giovane, i dotti scrivevano storia e i gentiluomini biografia”. Cioè i dotti, gli studiosi, dovevano tenersi il più possibile alla larga dal genere biografia, per evitare di sporcare la propria ricerca con tracce del proprio ego. Le biografie erano semmai roba da dilettanti. Per qualcuno c’era anche una ragione politica: negli anni Sessanta e Settanta ci si doveva occupare dei fenomeni, delle masse, delle popolazioni, dei movimenti, non dei singoli individui, tantomeno di singoli individui di successo o di potere. Presumo che il discorso in una certa misura valga ancora, sebbene forse meno ideologico.
Oggi le cose sono cambiate, e anche nella biografia di Marconi di cui ho parlato nel primo post di questa newsletter, alla fine, l’autore (uno storico, non primariamente uno scrittore) spiega le ragioni di alcune scelte e la sua fascinazione per il personaggio a cui si è tanto dedicato. Usa la prima persona, e in tempi di social network probabilmente non solo nessuno si scandalizza ma forse nessuno nemmeno lo nota.
Altre mani, solo per decorazione. Queste vengono da un libro di fisiognomica delle mani del 1917. Per la serie “vediamo solo quello a cui vogliamo credere”.
Ma qual era il punto. Forse, almeno per come lo leggo io, il problema era l’ingresso dei sentimenti, e anche inevitabilmente dei giudizi, in un racconto che si pensava dovesse sempre essere impersonale e (proviamoci) oggettivo. Quindi la perdita di una presunta e algida purezza che il lavoro del ricercatore dovrebbe avere. E qui, attenzione: proprio nel caso degli scienziati la contaminazione col fattore umano a lungo non è stata pacifica per niente.
Quando ho cominciato a fare questo lavoro erano i primi anni duemila: il mio maestro (indimenticato) si chiamava Romeo Bassoli ed era famoso nel giro per i giochi di parole e per certe espressioni buffe. Come quando rispondeva al telefono dicendo: “Romeo Lorenzo Bassoli di fu Giovanni”, o “il povero Bassoli”. Ecco, lui a noi giovani di bottega ripeteva sempre che ci vuole, nel lavoro di comunicazione della scienza, un po’ di “human touch”.
Me ne sono resa conto anni dopo, ma non era affatto una cosa scontata. Lo scienziato (quasi sempre maschio, più di adesso) molto spesso si voleva raccontare come un sacro produttore di conoscenza pura. Il genere peggiore (ce n’erano tanti, forse ci sono ancora) era quello che in università era conosciuto come uno scannapecore, barone culalcaldo, corrotto e piacione, seduttore di studentesse, iracondo e maneggione, e nemmeno se ne dispiaceva. Ma quando lo intervistavi dovevi chiamarlo Sua Maestà il Professore Bombone Sparone Pestafracassone, ripetendogli più volte il tuo ossequio per l’augusta gentilezza che stava mostrando proprio a te, misero giornalista. Ne ricordo uno dal doppio cognome che - proprio agli inizi della mia carriera - volle rileggere la sua intervista. Dopodiché, chissà perché insoddisfatto, mi rimandò un testo Pieno Di Maiuscole Inutili; E Di; punteggiatura assurda, lungo il triplo del dovuto, e poi mi telefonò per urlarmi una terribile; Minaccia Di Querela.
È morto.
Bravi, lo Stragenerale Bombone Sparone Pestafracassone è in guerra con il Mortesciallo Von Bombonen Sparonen Pestrafrakasson nel racconto “La guerra delle campane” di “Favole al telefono”, tuttora uno dei miei principali riferimenti letterari.
Ma torniamo alle biografie degli scienziati e delle scienziate. Da quanto detto fin qui si capisce come la biografia di Barbara McClintork scritta da Evelyn Fox Keller e pubblicata nel 1983 con il titolo “In sintonia con l’organismo”, sia stata inizialmente presa poco sul serio dagli storici (soprattutto maschi). Adesso invece è considerata un classico, e non solo per il contenuto principale ma anche per i significati che ebbe allora, le reazioni che suscitò.
Ora però, come si dice in tv, la domanda sorge spontanea: se gli storici cominciano ad ammettere l’uso della prima persona nelle biografie delle persone di scienza, se rivalutiamo lo “human touch” del biografante così come accettiamo l’umana imperfezione del biografato o della biografata, e accettiamo che la biografia sia anche l’espressione di un punto di vista o persino che sia strumentale a un’ideologia, quanto si può ammettere che noi raccontatori di scienza sfumiamo il genere verso qualcosa di più narrativo?
Per me, moltissimo. A maggiore ragione, ed è qui che vorrei far tornare la distinzione da cui sono partita nel numero scorso della newsletter, se a scrivere non è un accademico ma uno scrittore o una scrittrice.
Cioè: chi se ne frega, io voglio soprattutto leggere buoni libri. L’importante, per me, è che il patto con il lettore sia chiaro. Poi possiamo anche scrivere la biografia di uno scienziato immaginario o di una scienziata che non è mai esistita. Se siamo onesti nel dichiarare il lavoro che abbiamo fatto, di ricerca, di fantasia, o di entrambe le cose, perché no?
Questo è un po’ il dunque che avrei dovuto raggiungere diversemila battute fa.
Non ho niente contro la biografia romanzata. Se è chiaro che è romanzata, e non viene inserita tra i libri di testo di un corso di storia della scienza, la palla è nelle mani del lettore. E il lettore compra il libro che gli pare, legge come e quando gli pare, e se il libro gli piace lo regala agli amici. Funziona così.
Per esempio, a me sono piaciuti molto i libri di Benjamin Labatut (pubblicati in Italia da Adelphi), e su questo periodicamente bisticcio con i fisici. Sono romanzi che contengono storie di scienza parzialmente vere: il primo dei due (in Italia, “Quando abbiamo smesso di capire il mondo”) deve essere stato scritto in acido, il secondo (“Maniac”) è più classico ma mica tanto. Entrambi raccontano storie di scienziati considerati “intoccabili”, i mostri sacri della fisica del Novecento. Infatti i fisici si indignano.
Ma non ci vedo nessun sacrilegio: sono libri di narrativa che usano la scienza come materiale narrativo di base, e ne fanno una storia appassionante. In fondo Archimede Pitagorico è diventato un personaggio di Topolino, e dopo di lui centinaia di altri scienziati, e nessuno ha protestato. È chiaro a tutti che Topolino può prendersi le sue licenze poetiche.
Detto questo, non sento nemmeno nessuna contraddizione in me se dico che la mia biografia scientifica preferita è forse quella di Alan Turing scritta dal matematico Andrew Hodges (Bollati Boringhieri): lunghissima, lenta per i nostri standard di lettori degli anni venti del duemila, precisa fino alla noia, alle volte inaccessibile, e documentatissima. Ma mi è piaciuta, credo, soprattutto perché l’ho letta venti anni fa, e in quella fase della mia vita, e della mia vita di lettrice, e forse per l’epoca in generale, era giusta. Ricordo soprattutto la sensazione che a volte all’autore scappasse un sentimentalismo, un moto di affetto verso quell’Alan, ragazzo strano, ed era affetto trattenuto, che in una scrittura così compunta faceva quasi tenerezza.
Quanto a biografie di uscita più recente, vi segnalo “Maksimovic. La storia di Bruno Pontecorvo” (Castelvecchi) del fisico teorico e scrittore Giuseppe Mussardo, che ha appena vinto il Premio Cosmos. Io ammetto di averla solo cominciata, ma la storia è davvero interessante, Mussardo è un grande raccontatore, e chi l’ha già letta me ne ha parlato bene.
D’altra parte credo anche che le biografie, o comunque le storie delle persone, sia lecito usarle persino per alleggerire discorsi che altrimenti sarebbero pesanti. Per esempio mi è piaciuto molto “Costruire la vita – Quattro miliardi di anni, dai fossili al DNA” del biologo dell’evoluzione Neil Shubin (Adelphi), che unisce a una complessa spiegazione delle transizioni, o dei passaggi, morfologici della vita sulla Terra, per la quale attinge a paleontologia, biologia evolutiva, genetica e biologia dello sviluppo, pagine di biografie degli studiosi scritte con un linguaggio vivace.
Altre mani, stesso libro di cui sopra. L’ho messa per giustificarmi dicendo di avere le dita lunghe: non è colpa mia se mi perdo nei dettagli.
Intanto ho finito “Ucronia”, l’ultimo libro di Emmanuel Carrère (Adelphi): bello, divertente, intelligente, strano. Dopodiché, a proposito di ucronie, mi sono ricordata di aver apprezzato molto “Finitudine” di Telmo Pievani (Raffaello Cortina editore), che si inventa un incontro tra Albert Camus e Jacques Monod per costruire un “giallo filosofico”. Anche qui c’è tanta invenzione, tanto romanzo, e il patto con il lettore è chiaro: lo scienziato è esistito davvero ma per lui ci si inventa una vicenda mai accaduta, una storia che forse dovremmo chiamare una possibilità, una realtà controfattuale. Il risultato è che la biografia dello scienziato, da quel punto in poi, è inventata. Per questo direi che è una ucronia, un “nessun tempo, da οὐ = "non" e χρόνος = "tempo", come “utopia” significa "nessun luogo" (ho fatto lo scientifico e il greco lo copincollo senza capirlo).
Non ho sentito nessuno criticare Telmo per questo, nemmeno i fisici di cui sopra, che evidentemente sono ipersensibili quando si tocca Heisenberg ma sono molto meno sconvolti dalla costruzione di un personaggio letterario di nome Jacques Monod, che assomiglia in tutto e per tutto al vero Jacques Monod.
Comunque credo di essere un’ucronica anch’io, tutte le volte che mi dico che avrei dovuto scrivere di meno, e che lo sapevo che sarei andata lunga anche stavolta.